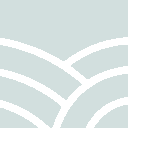- Home
- Chi siamo »
- Riviste
- Finestre
- Finestra sulla PAC
- Finestra sul WTO
- Finestra sull'Innovazione
- Collane
- Eventi
- E-learning
- Servizi
- My Space
- Profilo
- I miei gruppi
- I miei Articoli
- Preferiti
- Le mie notifiche
- SOCIAL
- @renews »
Glossario PAC iniziante con C
Il glossario con i termini della Pac
C
- capitale agrario
-
Componente dello Stato Patrimoniale delle imprese agricole calcolato come somma di macchine e attrezzature, capitale, bestiame, rimanenze o scorte di magazzino (materie prime e prodotti) e anticipazioni colturali finali.
- capitale fondiario
-
Componente dello Stato Patrimoniale di una impresa agricola costituito dal valore dei terreni, più gli investimenti fondiari voluti dall'uomo che apportano delle migliorie. Il reddito derivante dal capitale fondiario prende il nome di beneficio fondiario.
- capo azienda
-
Persona che di fatto gestisce l'azienda e cioè la persona fisica che assicura la gestione corrente e quotidiana dell'azienda. Si ha la gestione quotidiana dell'azienda anche quando l'attività è assicurata per un limitato numero di mesi come ad esempio nelle aziende specializzate per la viticoltura olivicoltura ecc.. Il capo azienda è in genere il conduttore stesso ma può essere una diversa persona qualora il conduttore stesso abbia affidato la gestione dell'azienda ad altra persona per esempio ad un membro della famiglia. Per ciascuna azienda si considera capo azienda esclusivamente una persona. Se più persone partecipano alla gestione corrente e quotidiana dell'azienda è considerato capo azienda la persona che reca il maggior contributo alla gestione della stessa. Qualora tale contributo alla gestione sia ripartito in maniera uguale tra due o più persone di queste è considerata capo azienda la più avanzata in età. Il mezzadro è da considerarsi come capo azienda ed analogamente il soccidario per le aziende a soccida.
- capping
-
A seguito della riforma della politica agricola comune per il periodo successivo al 2013, gli Stati membri possono scegliere di fissare un tetto all’importo del pagamento di base che ogni agricoltore riceve. L’ammontare dei fondi risparmiati tramite questo meccanismo resta nella gestione dello Stato membro interessato e viene trasferito alla dotazione per lo sviluppo rurale. Questa azione è volontaria per gli Stati membri ed è un’applicazione specifica della digressività.
- cartogramma
-
Rappresentazione cartografica che con opportuni simboli mette in evidenza la distribuzione di un dato fenomeno preso a oggetto di studio.
- Central America (CA)
-
Accordo di associazione tra Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.
Sinonimi: Central America CA
- Central European free trade agreement (Cefta)
-
Accordo originariamente firmato dai paesi del gruppo Visegrad (Repubblica Ceca Ungheria Polonia e Repubblica Slovacca) il 21 dicembre 1992 e in vigore dal luglio 1994. In seguito Slovenia (1996) Romania (1997) e Bulgaria (1999) hanno aderito al Cefta. Inoltre Lituana Lettonia Croazia Macedonia e Ucraina hanno annunciato la loro intenzione di aderire. L'accordo prevede il graduale stabilimento di una zona di libero scambio per i beni industriali e una graduale riduzione di alcune ma non tutte le barriere al commercio di prodotti agro-alimentari.
Sinonimi: Central European free trade agreement Cefta
- Centri di assisitenza agricola (Caa)
-
I Caa possono su incarico degli Organismi pagatori (es.: Agea Agrea) svolgere differenti attività per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto.
Sinonimi: Centri di assisitenza agricola Caa
- centro aziendale
-
Fabbricato, o il complesso dei fabbricati, connesso all’attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali. In assenza di fabbricati, il centro aziendale si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali.
- Centro ricerche produzioni vegetali (Crpv)
-
Il CRPV si occupa in generale dell'agroalimentare, lo scopo di tale società cooperativa è quello di promuovere la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione nel suddetto settore attraverso progetti ed attività riconducibili a tre ambiti operativi: filiera ortofrutticola e sementiera, vitivinicola e oleicola, grandi colture e bioenergie.
Sinonimi: Centro ricerche produzioni vegetali Crpv
- clausola de minimis
-
E' una sorta di "franchigia" nell'applicazione del vincolo di riduzione del sostegno interno previsto dall'Accordo sull'agricoltura. Essa consente di non conteggiare nella Mas le misure di sostegno direttamente attribuibili a un prodotto se il loro valore non supera il 5% del valore della produzione di quel prodotto; oppure nel caso di sostegno non direttamente imputabile a uno specifico prodotto se il suo valore è inferiore al 5% del valore della produzione agricola totale di un paese. Per i Pvs tale franchigia è elevata al 10%.
- clausola del trattamento nazionale (Tn)
-
E' uno dei principi del sistema commerciale multilaterale in base al quale i prodotti importati e quelli locali devono ricevere lo stesso trattamento. L'imposizione di una tariffa d'importazione non è una violazione di questo principio dal momento che essa avviene prima dell'ingresso dei prodotti sul mercato nazionale. La clausola vale per beni servizi e per gli altri prodotti oggetto degli accordi Wto con minime differenze dovute alla diversa natura dell'oggetto degli accordi.
Sinonimi: clausola del trattamento nazionale Tn
- clausola della nazione più favorita (Npf)
-
Principio di base che regola la riduzione della protezione commerciale su base multilaterale. La clausola Npf garantisce l'automatica estensione a tutti i paesi membri Wto di qualunque concessione commerciale accordata da un paese: "tutti i vantaggi benefici privilegi o immunità accordati da una parte contraente ad un prodotto originario o destinato a qualsiasi altro paese saranno immediatamente e senza condizioni estesi a tutti i prodotti similari o destinati al territorio di tutte le altre parti contraenti" (art. I Gatt).
Sinonimi: Nazione più favorita Npf Most favoured nation Mfn
- clausola di pace
-
Si tratta dell'impegno sancito dall'articolo 13 dell'Accordo sull'agricoltura dell'Uruguay round a non sollevare per nove anni a partire dal 1° gennaio 1995 dispute relative alle misure legittime sulla base dell'accordo stesso ed entro i limiti da esso previsti (per esempio i sussidi all'esportazione) ma non conformi alle regole generali Wto.
- clausola speciale di salvaguardia
-
Clausola speciale in materia agricola. Tale clausola prevista dall'Accordo sull'agricoltura e quindi applicabile ai soli prodotti agricoli consente a un paese importatore di imporre dazi aggiuntivi nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi all'importazione o un aumento delle quantità importate al di là di soglie prefissate. Tale clausola è applicabile ai prodotti le cui restrizioni commerciali sono state convertite in tariffe sulla base dell'accordo del 1994.
- Cluster
-
Nel contesto di programmi di sviluppo rurale, un polo (Cluster) è un raggruppamento di imprese indipendenti - start-up, piccole, medie e grandi come organi consultivi e/o organismi di ricerca - concepito per stimolare l’attività economica e innovativa promuovendo interazioni intensive, condivisione di servizi e scambio di conoscenze e competenze e di contribuire efficacemente alla diffusione di trasferimento, networking, informazioni econoscenza tra le imprese del polo.
- Codex alimentarius
-
Codice internazionale per gli alimenti creato e amministrato dalla Commissione "Codex alimentarius" delle Nazioni Unite.
- Coefficiente nazionale di protezione del consumatore (Ncpc)
-
Coefficiente nazionale di protezione del consumatore (Ncpc).
Sinonimi: Ncpc
- Coefficiente nominale di protezione del consumatore (Nacc)
-
Coefficiente nominale di protezione del consumatore (Nacc).
Sinonimi: Nacc
- coesione economica e sociale
-
L'Unione europea da sempre persegue l'obiettivo di ridurre le disparità economiche e sociali tra le sue diverse regioni attraverso la politica di coesione.
Le principali tematiche trattate sono:
- regioni con svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti
- le zone interessate da una transizione industriale
- le zone rurali
Con il trattato di Lisbona è stata aggiunta una terza dimensione: quella della coesione territoriale il cui scopo è pianificare congiuntamente un territorio e i suoi paesi confinanti ed implementare soluzioni ottimali per questioni come i trasporti, reti ecc.
I finanziamenti ai fini della coesione sono messi a disposizione da:
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
- Fondo europeo di sviluppo
- Fondo europeo di coesione
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Banca europea per gli investimenti.
- coltivazione principale
-
Si intende:
- la coltivazione unica vale a dire quella che è la sola ad essere praticata su una data superficie nel corso dell'annata agraria di riferimento;
- le coltivazioni erbacee consociate praticate sui seminativi nudi cioè quelle che si trovano simultaneamente sullo stesso terreno e ciascuna delle quali fornisce un raccolto ben distinto nel corso dell'annata agraria;
- le coltivazioni legnose agrarie consociate tra loro o con coltivazioni erbacee;
- la coltivazione successiva od intercalare più importante dal punto di vista economico praticate e raccolte l'una dopo l'altra su una determinata superficie nel corso della stessa annata.
- comitati
-
I comitati dei rappresentanti degli Stati Membri assistono alla commissione nello sviluppo e nell'applicazione delle politiche comunitarie e incoraggiano la cooperazione tra gli Stati Membri. Sono una struttura decisionale particolare dell'Unione ed un indispensabile ingranaggio della macchina amministrativa; trattano l'intero campo di questioni legali e di regolazione in discussione specialmente nell'area agricola (trattano approssimativamente 2000 testi ogni anno). I tre tipi di commissioni agricole sono: amministrative regolative e consultive. I Comitati amministrativi sono formati dai rappresentanti degli Stati Membri che trattano una specifica area. La maggior parte dei comitati Pac sono comitati amministrativi. Forniscono pareri sui piani della commissione per l'amministrazione dei mercati agricoli. Esiste un comitato amministrativo per ogni categoria di prodotto: cereali, latticini, carne bovina, vino, frutta e verdura, ecc. Quando le misure adottate dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato (preso a maggioranza qualificata) la Commissione lo deve comunicare al Consiglio che deliberando a maggioranza qualificata può prendere una decisione diversa.
- Comitato Economico e sociale europeo (Cese)
-
E' stato creato in quanto organo consultivo dal trattato del 1957 che ha istituito la Comunità economica europea con il compito di rappresentare gli interessi delle diverse categorie economiche e sociali. Esso è composto da 350 membri ripartiti in tre categorie: datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti di attività specifiche (agricoltori, artigiani, Pmi e industrie, professioni liberali, rappresentanti dei consumatori, rappresentanti della comunità scientifica e pedagogica dell'economia sociale delle famiglie dei movimenti ecologici). I membri del Comitato sono nominati per un mandato rinnovabile di cinque anni dal Consiglio che delibera all'unanimità. Il Cese è consultato preliminarmente all'adozione di un numero rilevante di atti relativi al mercato interno all'educazione alla tutela dei consumatori alla protezione dell'ambiente allo sviluppo regionale e al settore sociale. Esso può anche formulare pareri di propria iniziativa. Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (maggio 1999) il Cese deve essere consultato obbligatoriamente in merito ad un numero più vasto di temi (la nuova politica in materia di occupazione le nuove disposizioni in materia sociale la salute pubblica e le pari opportunità) e può essere consultato dal Parlamento europeo. Il trattato di Nizza entrato in vigore nel 2003 non ha modificato il numero dei membri e la ripartizione dei seggi per Stato membro in seno al Comitato. Esso ha però precisato la qualifica dei membri: il Cese è costituito da "rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata". La Costituzione europea in corso di ratifica prevede di fare passare il mandato dei membri del Cese da quattro a cinque anni.
Sinonimi: Comitato economico e sociale europeo Cese Eesc
- comitato sull'eliminazione del surplus
-
E' una sottocommissione del Comitato sui problemi delle materie prime della Fao che controlla i flussi degli aiuti alimentari per assicurare che la eliminazione dei surplus non interferisca con la normale produzione o con gli andamenti del commercio in conformità con i Principi sull'eliminazione dei Surplus della Fao.
- commercializzazione
-
Si intende l’attività di vendita di prodotti aziendali primari o trasformati svolta verso il mercato sia nazionale sia estero (esportazioni). I prodotti commercializzati possono anche derivare dall’annata agraria precedente, è necessario però che la commercializzazione sia stata effettuata nell’annata agraria di riferimento 2009-2010.
- Commissione europea
-
Istituzione collegiale politicamente indipendente, la Commissione europea incarna e difende gli interessi generali UE. Grazie al diritto di iniziativa quasi esclusivo sugli atti legislativi la Commissione è considerata il motore dell'integrazione europea. Nel quadro delle politiche comunitarie essa predispone ma anche attua gli atti legislativi adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La Commissione ha inoltre poteri di esecuzione di gestione e di controllo. Essa assicura in effetti la programmazione e l'attuazione delle politiche comuni esegue il bilancio e gestisce i programmi comunitari. In qualità di "custode dei trattati" essa vigila anche affinché sia applicata la legislazione europea. La Commissione è nominata a maggioranza qualificata per 5 anni dal Consiglio in accordo con gli Stati membri ed è soggetta al voto di investitura del Parlamento europeo dinanzi al quale è responsabile. Il collegio dei commissari è assistito da un'amministrazione composta da direzioni generali e da servizi specializzati il cui personale è ripartito principalmente tra Bruxelles e Lussemburgo. Fin dall'origine la Commissione è sempre stata costituita da due membri per i paesi più popolati e da un membro per ciascuno degli altri paesi. Il trattato di Nizza ha tuttavia limitato la composizione della Commissione ad un commissario per Stato membro. La Costituzione in via di ratifica prevede una Commissione ridotta a due terzi del numero degli Stati membri a partire dal 2014. I commissari saranno in questo caso scelti in base ad un sistema di rotazione in condizioni di parità .
- Community-led local development (Clld)
-
Un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali. La strategia di sviluppo locale dà vita ad un programma di interventi relativo a un territorio omogeneo, solitamente subregionale, che è gestito da un Gruppo di azione locale (Gal) e rappresenta gli interessi socio-economici locali pubblici e privati. È sostenuto principalmente da risorse per lo sviluppo rurale (Feasr) ma si avvale anche di risorse provenienti dai Fondi strutturali e dal Feamp.
Sinonimi: Community-led local development Clld
- complemento di programmazione
-
Si tratta di uno strumento introdotto da Agenda 2000 per taluni tipi di programmazione in particolare per le Iniziative comunitarie e per i cosiddetti "Programmi Obiettivo". E' il documento in cui sono specificate le misure descritte nei Programmi Operativi Regionali (Por) e che indica i modi di attuazione di ogni singolo intervento e la relativa ripartizione dei fondi strutturali (i PO sono cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e da quelli nazionali pubblici e privati). E' un approfondimento in cui sono descritte in dettaglio le informazioni relative al tipo di sostegno finanziario previsto dal Programma operativo: la natura delle azioni il tipo di beneficiario le spese ammissibili i requisiti di accesso ecc.. Il Complemento di programmazione deve essere trasmesso alla Commissione europea per informazione.
- comunità dei paesi andini (Can)
-
Accordo di associazione tra Colombia, Ecuador, Bolivia e Peru.
Sinonimi: comunità dei paesi andini
- concentrazione
-
E' il frutto della combianzione giuridica tra due o più imprese precedentemente indipendenti mediante fusione o acquisto. Le operazioni di concentrazione possono avere un impatto positivo sul mercato, ma sono anche suscettibili di limitare sensibilmente la concorrenza, creando o rafforzando un attore dominante.
Al fine di prevenire il rischio di eventuali restrizioni di concorrenza, la Commissione europea esercita un controllo sui progetti di concentrazione di dimensione comunitaria (cioè quando l’operazione supera le frontiere di un paese dell’UE e talune soglie di fatturati sul piano mondiale ed europeo). Può quindi autorizzarle a determinate condizioni o vietarle. - condizionalità
-
Per poter beneficiare dei pagamenti diretti ogni agricoltore è tenuto a rispettare la condizionalità. Essa è l’insieme dei criteri di gestione obbligatori (Cgo) già previsti dall’UE nella normativa esistente e il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa) fissate a livello nazionale, con riferimento a:
- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali.
- condizionalità ex ante
-
La gestione della programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 deve avvenire nell’ambito di alcune condizioni minime garantite – per lo più di carattere normativo, amministrativo e organizzativo – che dovrebbero migliorare la possibilità di assicurare l’efficienza e l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale. L’assenza di una o più di queste condizioni mette lo Stato membro e le Autorità di gestione dei programmi nella necessità di definire un percorso con precisi impegni per il loro soddisfacimento, con il potenziale blocco nell’erogazione dei pagamenti comunitari se in fase di verifica ex post (nel 2019) venisse verificato il mancato rispetto degli impegni assunti.
- conduttore
-
Responsabile giuridico ed economico che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione. Il conduttore può essere una persona fisica, una società o un ente.
- conduzione a colonia parziaria appoderata
-
Mezzadria. Contratto agrario in base al quale una persona fisica o giuridica (concedente) affida un podere ad un capo famiglia (mezzadro) il quale si impegna ad eseguire con l'aiuto dei familiari (famiglia colonica) tutti i lavori che il podere richiede sostenendo parte delle spese necessarie alla conduzione e dividendone i frutti con il concedente in determinate proporzioni.
Sinonimi: conduzione a colonia
- consiglio dell'Unione Europea
-
Il Consiglio dell'Unione europea ("Consiglio dei ministri" o "Consiglio") è l'istanza decisionale preminente dell'Unione europea. Esso riunisce i ministri degli Stati membri ed istituisce pertanto l'Unione nel cui ambito sono rappresentati i governi degli Stati membri. Il Consiglio esercita congiuntamente al Parlamento le funzioni legislative e finanziarie. Esso è inoltre l'istituzione preponderante nell'adottare decisioni in materia di politica estera e di sicurezza comune (Pesc) e di coordinamento delle politiche economiche (approccio intergovernativo). Il Consiglio si riunisce in varie formazioni nel cui ambito si incontrano i ministri degli Stati membri competenti per i settori interessati: affari generali e relazioni estere affari economici e finanziari occupazione politica sociale salute e consumatori competitività ecc. La sede del Consiglio è a Bruxelles dove esso si riunisce varie volte al mese (in taluni mesi le riunioni hanno luogo a Lussemburgo). Ciascun paese dell'Unione europea esercita la presidenza secondo un sistema di rotazione per un periodo di sei mesi. Le decisioni del Consiglio sono preparate dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper) che è assistito da gruppi di lavoro composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. Nella maggioranza dei casi il Consiglio decide su proposta della Commissione europea in codecisione con il Parlamento europeo. In funzione dei settori da esaminare esso delibera a maggioranza semplice a maggioranza qualificata o all'unanimità. Nondimeno esso prende perlopiù le decisioni a maggioranza qualificata (agricoltura mercato unico ambiente trasporti occupazione salute ecc.). La Costituzione europea in via di ratifica prevede che il Consiglio decida un nuovo sistema di esercizio della presidenza. La presidenza del Consiglio è esercitata da un gruppo di tre Stati membri determinati per un periodo di 18 mesi. Ciascun paese esercita la presidenza per un periodo di sei mesi ed è assistito dagli altri due paesi sulla base di un programma comune. Il Consiglio Affari generali sarà inoltre presieduto dal ministro degli Affari esteri nuovo posto creato dalla Costituzione. La Costituzione ha previsto da ultimo di modificare fondamentalmente il sistema della votazione a maggioranza qualificata nell'ambito del Consiglio.
Sinonimi: consiglio ue
- consiglio europeo
-
Il Consiglio europeo è costituito dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione che tengono riunioni a scadenze regolari. Il suo compito è di stabilire gli orientamenti politici generali e d'imprimere all'Unione europea l'impulso necessario al suo ulteriore sviluppo. Esso non legifera. Istituito col comunicato finale del vertice di Parigi del dicembre 1974 il Consiglio europeo si è riunito per la prima volta nel 1975. Esso si è sostituito alla prassi delle conferenze europee al vertice che hanno caratterizzato il periodo 1961-1974. L'esistenza del Consiglio è stata giuridicamente consacrata dall'Atto unico europeo (1986) ed è ufficializzata dal Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht 1992). E' convocato almeno due volte l'anno e conta tra i suoi membri il presidente della Commissione europea in quanto membro di diritto. E' presieduto dallo Stato membro che esercita per sei mesi la presidenza dell'Unione europea secondo un determinato ordine. La Costituzione in via di ratifica prevede di attribuire al Consiglio europeo lo statuto di istituzione europea. Essa prevede inoltre di modificare il sistema della presidenza del Consiglio europeo e di creare la funzione permanente di presidente del Consiglio europeo per una durata di due anni e mezzo.
- consulenza aziendale
-
Entro il 1° gennaio 2007 gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione della terra e dell'azienda agricola. L'attività di consulenza è incentrata sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali. Il sistema funziona su base volontaria. Gli Stati membri accordano la priorità agli agricoltori che ricevono più di 15.000 euro l'anno in pagamenti diretti. Entro il 1° gennaio 2011 la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento del sistema di consulenza eventualmente corredata di proposte per renderlo obbligatorio.
- Consumer support estimate (Cse)
-
Un indicatore calcolato dall'Ocse/Oecd del valore annuale monetario dei trasferimenti all'ingrosso a (da) consumatori di materie prime agricole misurate al livello delle dogane agricole (primo consumatore) derivanti da misure politiche che sostengono l'agricoltura indifferentemente dalla loro natura obiettivi o impatti sul consumo di prodotti agricoli. Il Cse include trasferimenti impliciti ed espliciti da consumatori associati con: supporto ai prezzi di mercato su beni di consumo prodotti all'interno della nazione (trasferimenti a produttori da consumatori); trasferimenti ai budget e/o agli importatori sulla quota dei beni di consumo che l'importato (altri trasferimenti da consumatori). E' al netto di qualunque pagamento ai consumatori per ricompensarli per il loro contributo al sostegno del prezzo di mercato di una specifica materia prima (sussidi ai consumatori da coloro che pagano le tasse); e il contributo dei produttori (come consumatori di colture prodotte nazionalmente) al sostegno dei prezzi di mercato sulle colture usate nel mangime per animali (eccesso di spese per mangime). Quando assumono valori negativi i Cse misurano la tassa implicita sui beni di consumo associata con le politiche del settore agricolo. Anche se le spese per beni di consumo è incrementato o ridotto dall'ammontare dei sussidi/tassi impliciti questo indicatore non è da solo una stima dell'impatto della spesa per beni di consumo (a prezzi della dogana agricola). La percentuale Cse è il rapporto tra il Cse e il valore totale delle spese di consumo sulle materie prime prodotte nazionalmente (a prezzi di dogana agricola) meno i sussidi ai consumatori. La nomenclatura e la definizione di questo indicatore ha sostituito il Consumer Support Equivalent dal 1999.
Sinonimi: Consumer support estimate Cse
- consumi finali
-
Secondo la definizione dell'Istat rappresentano il valore dei beni e servizi impiegati per soddisfare direttamente i bisogni umani siano essi individuali o collettivi. Sono utilizzati due concetti: la spesa per consumi finali e i consumi finali effettivi. La differenza fra i due concetti sta nel trattamento riservato ad alcuni beni e servizi che sono finanziati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie ma che sono forniti alle famiglie come trasferimenti sociali in natura; questi beni sono compresi nel consumo effettivo delle famiglie mentre sono esclusi dalla loro spesa finale. (Sistema europeo dei conti Sec)
- consumi intermedi
-
Il valore dei beni e dei servizi consumabili quali input in un processo di produzione, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivi.
- contabilità pubblica
-
E' il complesso delle norme che disciplinano l'attività di gestione degli Enti pubblici comprendente - fra l'altro - la loro organizzazione finanziario-contabile e la gestione del loro bilancio.
- Contabilità verde
-
è uno strumento per comprendere il ruolo svolto dall'ambiente naturale nell'economia, un insieme di dati aggregati che legano l'ambiente all’economia. La contabilità ambientale fornisce dati per evidenziare il contributo delle risorse.
Sinonimi: Contabilità ambientale
- contabilità nazionale
-
Insieme di tutti i conti economici che descrivono l'attività economica di un Paese o di una circoscrizione territoriale. Essa ha per oggetto l'osservazione quantitativa e lo studio statistico del sistema economico o dei sub-sistemi che lo compongono a diversi livelli territoriali.
- conti economici nazionali e territoriali
-
Secondo la definizione dell'Istat sono i quadri sintetici delle relazioni economiche che si hanno tra le differenti unità economiche di una data comunità in un determinato periodo. Essi riportano in un certo ordine le cifre relative alla situazione economica del Paese o di un suo territorio sulle risorse disponibili e sul loro uso sul reddito che si è formato e sulle sue componenti sul processo di accumulazione e sul suo finanziamento sulle relazioni con il resto del mondo e su altri fenomeni. Attualmente i conti economici territoriali sono pubblicati da Istat con uno sfasamento temporale di circa due anni rispetto ai dati nazionali (solo per alcuni aggregati è disponibile la stima ad un anno di distanza).
- conto consolidato
-
Conto relativo al complessivo universo di Enti di riferimento il quale si ottiene individuando ed elidendo i flussi finanziari che costituiscono trasferimenti tra gli Enti considerati cioè attraverso l'operazione contabile di consolidamento grazie alla quale si evitano duplicazioni e pertanto sovrastime dell'effettivo ammontare delle risorse finanziarie gestite dal Settore pubblico a livello nazionale e/o regionale.
- conto economico
-
Documento contabile composto secondo i criteri della competenza economica in cui sono evidenziati in modo analitico gli elementi positivi (ricavi) e negativi (costi) conseguenti alla gestione di un organismo (impresa o anche ente pubblico) dalla cui somma algebrica si ottiene il risultato economico (reddito o perdita) della gestione dell'esercizio considerato.
- conto finanziario
-
O conto del bilancio. Documento contabile redatto in termini sia di competenza (accertamenti/impegni) che di cassa (riscossioni/pagamenti) i cui elementi attivi e passivi portano a dimostrare l'esito della gestione rispetto alle previsioni iniziali; anch'esso si conclude con la dimostrazione sia del risultato contabile di gestione che di quello di amministrazione in termini di avanzo disavanzo o pareggio.
- contoterzismo
-
Per contoterzismo attivo si intende l’attività svolta in altre aziende agricole con l’utilizzo di mezzi meccanici di proprietà o di comproprietà dell’azienda con propria manodopera aziendale. Per contoterzismo passivo si intende l’utilizzo in azienda di mezzi meccanici e relativa manodopera forniti da terzi, cioè da altre aziende agricole, da organismi associativi o da imprese di esercizio e di noleggio.
- contratti di magazzinaggio privato
-
Ammasso privato. Attraverso l'ammasso privato di prodotti agricoli l'Unione europea è in grado di stabilizzare i mercati agricoli con un impatto minimo sui circuiti di commercializzazione tradizionali. Con la perdita di importanza dell'intervento l'ammasso sta divenendo il principale strumento di gestione dei mercati. L'obiettivo di tale misura è di allentare la pressione sull'offerta ritirando parte del prodotto dal mercato - di cui i produttori continuano a mantenere la proprietà - con un effetto al rialzo sui prezzi. Lo scopo è di differire la vendita del prodotto ad un periodo successivo in cui le condizioni di mercato dovrebbero essere migliorate. Allorché i prezzi sul mercato si abbassano oltre una certa soglia le agenzie di intervento dello Stato membro possono concludere contratti di ammasso con una società privata nel rispetto della normativa dell'Unione europea nel quadro del quale sono messi a disposizione i fondi necessari per il rimborso delle spese di ammasso e a copertura degli interessi per il capitale immobilizzato.
- Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl)
-
Gli accordi e i contratti stipulati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con riferimento ai diversi comparti di attività economica.
Sinonimi: Contratto collettivo Ccnl
- contributi alla produzione
-
Con l’entrata in vigore nel 2005 della riforma della Pace l’introduzione del pagamento unico per azienda è stata rivista la classificazione degli aiuti che prima confluivano nel prezzo base. Ora vengono classificati in: Contributi ai prodotti, Altri contributi alla produzione e Contributi per altre attività economiche. Solo la prima categoria contributi ai prodotti rientra nella valutazione del prezzo base.
- convergenza esterna
-
Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, riducendo il legame con i riferimenti storici, i pagamenti diretti per ettaro subiranno un progressivo adeguamento verso un valore più omogeneo. Gli Stati membri che hanno un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media dell’Unione colmano un terzo della differenza fra il loro livello attuale e il livello medio comunitario in 6 anni, così che entro il 2020 tutti gli Stati membri raggiungano un livello minimo, pari a 196 euro/ha. Tale convergenza viene finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di livelli di pagamenti diretti superiori al livello della media comunitaria (tra cui l’Italia).
- convergenza interna
-
La convergenza interna è un meccanismo che permette a uno Stato membro di avvicinarsi a un flat rate, ossia a un aiuto uniforme a tutto il territorio nazionale o regionale, senza raggiungerlo e prevede, di conseguenza, il mantenimento di un valore differenziato dei titoli. Il meccanismo di convergenza sarà applicato gradualmente, secondo tappe predefinite a partire dal 2015. Al più tardi nel 2019, nessun diritto all’aiuto di base dovrà avere un valore inferiore al 60% del valore medio unitario nazionale o regionale. L’aumento del valore dei titoli di quelli che stanno sotto la media sarà finanziato dalla riduzione del valore dei titoli di quelli che stanno sopra la media. Gli Stati membri hanno la possibilità di fissare una perdita massima per beneficiario pari al 30% del valore unitario iniziale dei titoli.
- costi di transazione
-
Sono costi aggiuntivi rispetto al prezzo che vengono sostenuti per il trasferimento di beni e servizi tra diversi attori economici. Essi includono i costi di negoziazione (quelli che servono a trovare e valutare le possibili alternative), di registrazione (che sono necessari per rendere effettiva la transazione) e quelli necessari per assicurarsi il rispetto degli impegni assunti nel contratto.
- costi diretti
-
I costi diretti sono i costi direttamente connessi ad una attività, dove può essere dimostrato il legame con la singola attività (ad esempio, attraverso la registrazione diretta).
- costi indiretti
-
I costi indiretti di solito sono i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad una attività specifica. Tali costi possono comprendere le spese amministrative, per le quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile a ciascuna attività come ad esempio: i costi di gestione, le spese di assunzione, i costi per il commercialista o per le pulizie, telefono, acqua o le spese di energia elettrica, ecc.).
- costi intermedi
-
Valore dei beni e servizi acquistati sul mercato dall'azienda e da essa utilizzati per il conseguimento della produzione.
- costo del lavoro
-
Il costo del lavoro comprende tutte le voci che costituiscono le remunerazioni del personale dipendente sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato: retribuzioni lorde, contributi sociali e accantonamenti per trattamento di fine rapporto.
- countercyclical payments
-
I pagamenti anticiclici sono una forma di sostegno presente nella politica agricola statunitense; in breve l'agricoltore riceve la differenza tra un prezzo obiettivo ed il prezzo effettivamente ricevuto dal mercato. I pagamenti anticiclici presentano alcune caratteristiche che ne hanno permesso l'inserimento nella scatola blu nella classificazione del sostegno interno in ambito Wto (ad esempio sono effettuati in base a rese non effettive bensì storiche; entro certi limiti non vi è obbligo di coltivazione).
- credito
-
Impieghi totali delle banche Sofferenze.
- credito all'esportazione
-
Sostegno finanziario governativo, finanziamento diretto, garanzia, assicurazione o sostegno ai tassi di interesse forniti da un determinato Paese agli importatori stranieri per aumentare la convenienza delle proprie esportazioni.
- Criteri di gestione obbligatoria (Cgo)
-
Riguardano il rispetto di 18 atti comunitari in materia ambientale di sicurezza alimentare di salute degli animali e delle piante e di benessere degli animali già vigenti nell'ordinamento comunitario il cui rispetto è ora divenuto prerequisito per ottenere gli aiuti diretti (condizionalità).
Sinonimi: Criteri di gestione obbligatoria Cgo
- cross-compliance
-
Imposizione di condizioni di rispetto salvaguardia e/o valorizzazione ambientale come contropartita di una politica di sostegno all'agricoltura. Nel dibattito europeo i termini cross-compliance, eco-condizionalità o condizionalità ambientale sono utilizzati in modo intercambiabile per indicare la subordinazione del sostegno alle imprese agricole a condizionamenti ambientali. Nelle riforma Fischler del 2003 ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti sia di quelli che ricadono nel pagamento unico che di quelli che ne sono al momento esclusi è tenuto al rispetto delle norme individuate nell'ambito della condizionalità. Essa riguarda sia criteri di gestione obbligatoria (Cgo) che il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa). Il mancato rispetto delle norme imposte dalla condizionalità comporta una riduzione degli aiuti diretti fino alla loro completa soppressione.